

Il "San Luca" di Vallo della Lucania, DEA I° livello, è un presidio ospedaliero appartenente all'Azienda Sanitaria
Locale (A.S.L.) Salerno.
L'ospedale, ha una capacità ricettiva di 280 posti letto, eroga prestazioni nelle seguenti U.O. :
UTIC-Cardiologia, C.O.T. 118, PS e Medicina d’Urgenza, Anestesia e Rianimazione, Chirurgia generale, Chirurgia vascolare, Gastroenterologia, Malattie Infettive, Medicina generale, Neurologia, Neurochirurgia, Neuroradiologia, Oculistica, Oncologia, Ortopedia e traumatologia, Ostetricia e ginecologia, Otorinolaringoiatria, Laboratorio analisi e Patologia clinica, Pediatria e nido, Radiologia, Urologia, Farmacia, Anatomia e Istologia patologica, Immunoematologia e Medicina trasfusionale, Riabilitazione, Terapia Antalgica.
La storia dell’ospedale di Vallo della Lucania è nata sul monte Gelbison, presso il Santuario del Sacro Monte, ad un’altezza superiore ai 1700 metri. A scrivere la prima pagina di questa lunga storia fu, agli inizi del secolo, il canonico Don Luca Petraglia.
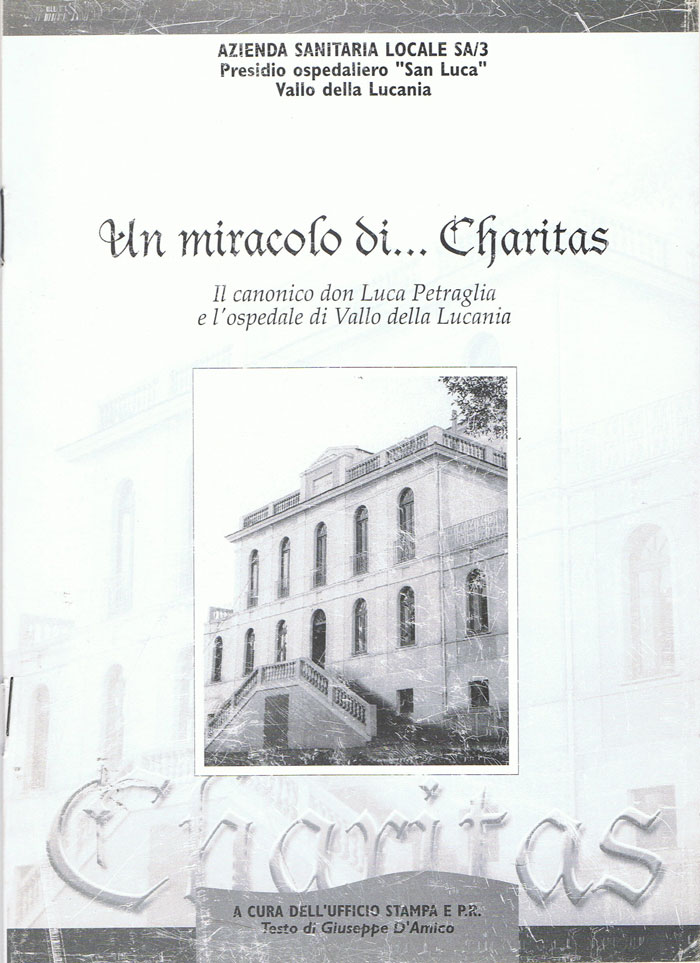
Don Luca era nato a Piaggine il 18 dicembre del 1869; ordinato sacerdote era rimasto a Vallo della Lucania dove gli veniva affidata la responsabilità del Santuario del Sacro Monte di cui fu rettore per mezzo secolo, dal 1898 al 1947, anno della scomparsa. Di Don Luca moltissimi hanno sentito parlare tanto che ancora oggi, in questo sacro luogo, i pellegrini parlano di Lui con venerazione, comunque con il massimo rispetto. Non tutti, però, conoscono il suo impegno per la costruzione di un ospedale a Vallo della Lucania.
È nel lontano 1910 che don Luca pensa per la prima volta di costruire un ospedale per i poveri del circondario. I problemi, le miserie sentite raccontare sul Santuario dalle migliaia di pellegrini che vi arrivavano (ma vi arrivano sempre più numerosi ancora oggi) dal Cilento, dalle altre zone della Campania, dalla Calabria, e dalla Basilicata per chiedere intercessione, oppure una grazia, alla venerata Vergine del Sacro Monte, avevano avuto una parte importante nella decisione del dinamico sacerdote. In tutta la zona, infatti, non esisteva alcun ospedale per cui i miseri tuguri degli ammalati poveri, tante volte, diventavano sale operatorie da parte di ardimentosi medici, con risultati non sempre positivi.
Erano anni difficili, soprattutto per il Sud d’Italia, ancora lontano dalla realizzazione del tanto auspicato processo unitario del paese iniziato col Risorgimento. Erano anni in cui lo Stato era afflitto da gravi problemi, soprattutto economici, per cui necessitava un’opera di supplenza. E di quest’opera di supplenza, soprattutto nel campo della scuola e dell’assistenza sanitaria, proprio la Chiesa si è sempre fatta carico. Non a caso i primi ospedali nascono come estensione architettonica di monasteri, chiese e castelli: tali luoghi di ricovero rispecchiano, infatti, i canoni morfologici del complesso edilizio in cui trovano accoglimento. Accanto alla funzione di soccorrere e di prestare aiuto agli ammalati gli ospedali erano portatori di un valore: la rappresentazione di un cristianesimo praticato attraverso l’assistenza spirituale. Forse proprio per questo don Luca, che in un primo momento pensava di realizzare un ospizio per i poveri, cambia idea e decide di fondare un ospedale dove i poveri avrebbero potuto trovare gratuitamente assistenza, igiene, conforto e tutto quello che loro abbisogna, e di cui, causa la miseria, sono privi nelle loro case.
Per far conoscere la propria idea, nel 1911 Don Luca fonda un giornale a cui dà un nome semplice ma significativo al tempo stesso: Charitas. Il giornale viene stampato a Napoli, presso la Tipografia Giannini, e si avvale di un disegno di copertina molto prestigioso realizzato dall’architetto Salvatore De Mattia, discendente di una gloriosa famiglia che nel secolo scorso aveva dato alcuni martiri per l’unità d’Italia, ed egli stesso autore di alcuni prestigiosi progetti tra i quali Piazza Vittorio Emanuele, il Palazzo Municipale e Piazza dei Martiri. Per la copertina del Charitas Salvatore De Mattia realizza una figura biblica, il pietoso samaritano che medica il pellegrino, ferito e lasciato morente dai predoni. Il Charitas: non sembri un capriccio o un qualcosa di poco conto perché la nascita di un giornale è sempre un fatto importante sia dal punto di vista sociale che culturale. Erano gli anni in cui si riaffermavano certe contrapposizioni politiche per cui si era convinti che per fondare un partito è necessario fondare un giornale. E per il canonico Petraglia Charitas era un giornale vero. Basta dare uno sguardo ai primi numeri per rendersene conto: non ci sono soltanto appelli a contribuire alla realizzazione dell’ospedale ma anche articoli di vario genere, poesie e commenti. Addirittura, nel primo numero, troviamo lo schizzo di un disegno di straordinario valore opera di Domenico Morelli, uno dei più importanti pittori napoletani della seconda metà del secolo scorso, che trattò temi storici e religiosi con accesi toni drammatici e intenso verismo.
Nel nome del giornale, Charitas, è racchiuso tutto il programma del giornale che viene pubblicato con periodicità bimestrale: ”promuovere la fondazione di un ospedale. Il giornale -si legge nella copertina- viene spedito gratis. Si accetta, però, con viva riconoscenza qualsiasi offerta, sia per le spese di stampa, sia per l’ospedale erigendo”. Nell’editoriale di presentazione don Luca scrive: “Un’ardimentosa idea da anni mi riscalda il cuore e la mente. L’ho sempre vagheggiata come un sogno lontano, non ignaro punto degli ostacoli e delle amare delusioni che incontrerò sul cammino... Quest’idea è la fondazione di un ospedale in queste terre lucane in beneficio degli infermi poveri, per alleviarne in qualche modo le amarezze della vita. L’impresa, lo so, è ardua, ma non del tutto irrealizzabile, poiché per le largizioni di alcune persone generose, fin da ora dispongo di una somma considerevole. E poi fo fidanza anche sul vostro aiuto, lettori carissimi. Da voi spero che non solo vogliate interessarvi di accogliere delle offerte, siano anche minime, per l’erezione dell’ospedale, ma farvene propagatori con gli amici, coi conoscenti e colle persone che in un modo qualunque potessero avvantaggiare l’opera”.
E che don Luca fosse dotato di una forte carica comunicativa lo si evince dalla lettura degli slogans che pubblicava sul giornale che finanziava con le offerte e con la pubblicità:
Tutti sentono la mancanza di un ospedale nel nostro Circondario, tutti debbono cooperarsi per raggiungere lo scopo.
Cittadini della Lucania, non dormite: pensate che l’ospedale che dovrà sorgere un giorno potrà esser utile a tutti!
Se si vuole che presto sorga il nostro ospedale concorra ciascuno con quello che gli è possibile, fosse anche con la parola.
Strano che mentre gli uomini si occupano a formare financo società per la protezione degli animali, non si curino poi gran fatto di soccorrere i loro simili.
Dal vescovo di Capaccio-Vallo, mons. Paolo Iacuzio, l’11 febbraio del 1911 don Luca riceve una lettera di incoraggiamento in cui, tra l’altro, si legge: “... Non ci stanchiamo di fare del bene. Questo consiglio io lo rivolgo a Voi, carissimo Don Luca, a voi che con tanto slancio avete intrapreso l’ardua opera di fondazione di un ospedale in questo circondario, in cui più di ogni altra cosa si risente la deficienza di sì benefica istituzione. La vostra impresa è difficile e ingrata. Ma io in nome di Dio vi dico: coraggio e avanti.” Altri incitamenti pervengono dall’arcivescovo di Benevento, mons. Benedetto dei Conti Bonazzi, dal vescovo di Bergamo, mons. Giacomo Maria Radini Tedeschi, dal prof. Nicola Di Lorenzo e tanti altri ancora. Inoltre, Don Luca può beneficiare di un lascito testamentario del cav. Raffaele Passarelli di Vallo della Lucania il quale, morto nel 1900, aveva destinato “a scopo di pubblica beneficenza l’annua rendita di lire centosettanta a carico dell’erede. Tale rendita annua dovrà versarsi a favore del primo, per ordine di tempo, Ospedale Civico che sorgesse in questo Comune a cominciare dal tempo della fondazione, e finché ciò non avviene lo impiegherà l'erede con detto scopo come meglio crederà, a cominciare dal decesso del testatore.”
Per dovere di cronaca va ricordato che il figlio, Gaetano Passarelli, fu scrupoloso esecutore della volontà paterna. Nel giugno del 1911 la rendita ammontava a lire 4.600! Oltre agli incoraggiamenti arrivano, quindi, anche le prime sostanziose offerte che don Luca provvede ad annotare con precisione notarile sul periodico. I primi benefattori dell’opera sono il vallese Tommaso Campanile fu Pietro che offre, per ora, lire mille e il signor Gaetano di Polito fu Michele di Novi Velia che offre lire cinquecento. Seguono con offerte inferiori il rev.do don Gaetano Marino di Castelnuovo Cilento, il pretore di Napoli Vincenzo Rispoli; Carmela Giannini Rispoli, Concetta Lente e Nunziatina Crispi di Napoli, il cavaliere Alessandro Delli Paoli dagli Stati Uniti d’America, il suddiacono Alfredo Pinto ed il sacerdote don Domenico Pignataro di Vallo della Lucania, Irene Ferola di Maratea, Pietro Galzerano di Moio, Rachele Mautone e Francesco Maiese di Vallo della Lucania. Altri cospicui contributi don Luca li riceve dai numerosi pellegrini che, provenienti da tutto il Meridione, si recano a pregare sul Monte Sacro. Con le somme disponibili, nel gennaio del 1913 don Luca investe le prime 7.000 lire di quanto raccolto ed acquista dai germani Alfredo, Roberto e Giovanna Stasi un vasto appezzamento di terreno, circa 1.000 metri quadrati, sito in Via Nazionale.Nell’atto, stipulato dai contraenti dinanzi al notaio Tipoldi, viene espressamente specificato che il terreno veniva acquistato per erigervi un ospedale “per spontanea iniziativa del canonico Luca Petraglia”. Notevole la cerimonia della posa della prima pietra. I lavori, però, a causa degli eventi della guerra mondiale del 1915-18, che interessano anche il Cilento, proseguono con una certa lentezza.
Don Luca, però, non abbandona l’idea originaria e ritorna alla carica nel 1919 “con fede più viva, con sicure e più ardite speranze attinte a un doloroso passato”. Don Luca così scrive: “L’ospedale ci vuole: lo reclama la civiltà, la giustizia, il cuore. Io lo sento e il cuore è profeta.” Il momento difficile continua anche perché, almeno all’inizio, il fascismo non favorisce la nuova Opera. Anzi, don Luca inizia apre un duro contenzioso con i responsabili del fascio di Vallo, fermamente decisi ad impedire la realizzazione dell’opera (sembra, per favorire interessi privati). Solo nel 1928 riesce a spuntarla e dà inizio ai lavori per la realizzazione del primo edificio che, almeno per quanto riguarda la struttura, chiama IL SAMARITANO.
La struttura viene completata solo nel 1938, anche se ancora priva dei pavimenti, degli infissi e di tutto l’arredamento. Don Luca ha speso tutto quanto aveva raccolto: 300.000 lire per cui occorre altro denaro. Per dare nuovo impulso all’iniziativa, nel 1939 don Luca fonda un nuovo giornale, IL SAMARITANO, questa volta mensile, che prende il posto del Charitas. Anche in questa occasione si avvale della preziosa collaborazione giornalistica dell’avvocato Gaetano Di Vietri, vero motore del periodico, che fin dall’inizio aveva affiancato il religioso nell’impresa avviata per realizzare quella che a molti sembrava un’utopia. “Lucani - scrive il sacerdote su IL SAMARITANO - mostrate come sempre di avere un cuore nobile e liberale che farà onore a voi e ai vostri paesi. Aiutatemi. Vorrei che per il 1940-41 potessimo già ospitare i primi poveri”.
Da parte sua, l’avv. Di Vietri aggiunge che la raccolta dei fondi procede e, dopo avere dato notizia delle ultime offerte pervenute al canonico, comunica che la famiglia Pinto fu Scipione ha deciso di farsi carico delle spese necessarie per la messa in opera di una sala o corsia dell’ospedale (intonaco, pavimenti, pittura) annuncia che Giuseppe Senatore, un vallese emigrato in America del Sud ha dato il via ad una sottoscrizione pubblica tra i concittadini allo scopo di concorrere a realizzare l’alto scopo che anima il cuore di Don Luca: ”Noi - aggiunge Di Vietri - non ci stanchiamo di chiedere. Noi busseremo sempre perché il lavoro di raccolta di fondi, suppellettili, biancheria, sia fervido, continuo, insistente…”.
La tenacia, la perseveranza e la sottile diplomazia di don Luca e dei suoi collaboratori ottengono un altro risultato importante nel 1940 allorquando viene sanato il dissidio con l’Amministrazione Comunale di Vallo: il 21 dicembre il podestà, cav. Raffaele Passarelli, nipote del primo benefattore dell’erigendo ospedale, adotta un atto deliberativo con il quale, dopo avere ricordato che nella lunga fascia da Salerno a Sapri non esiste alcun ospedale civico, in considerazione degli scopi che l’attività di don Luca si prefigge, delibera:
Anche stavolta, però, i lavori procedono a rilento e rischiano di fermarsi del tutto quando, l’8 giugno del 1947, sul Monte Sacro don Luca Petraglia si spegne dopo una breve malattia.
- esternare al Rev. canonico Luca Petraglia, per la solerte opera che va compiendo per dotare questo comune di un civico ospedale, i più vivi ringraziamenti ed i sensi di gratitudine dell’intera cittadinanza;
- facilitare, per quanto possibile e per quanto sia facoltà dell’Amministrazione Comunale, la benefica funzionalità del nuovo Istituto, che ha carattere prettamente comunale e che viene eseguito nell’interesse esclusivo della popolazione;
- assegnare, infine, un contributo di lire trentamila per accelerare il compimento dell’opera, da corrispondersi nella misura di annue lire cinquemila per anni sei.
Prima di morire, però, aveva già pensato di donare l’ospedale al vescovo con l’obbligo di accogliere gratuitamente gli ammalati poveri dei paesi dove si estende il culto della Madonna del Sacro Monte. Del consiglio di amministrazione avrebbe dovuto far parte un rappresentante del Capitolo Cattedrale. Chiedeva al vescovo di formare subito un comitato provvisorio per provvedere a quant’altro manca dell’arredamento. Le indicazioni di Don Luca non vengono disattese e la sua opera non si interrompe. Il 7 luglio del 1947, ad un mese dalla scomparsa del canonico, il capitolo cattedrale si riunisce per esaminare il testamento olografo circa l’ospedale sottoscritto da don Luca il 30 maggio 1937, con postilla del 3 aprile 1945.
In questo documento si legge quanto segue:
L’ospedale IL SAMARITANO da me fino al momento che scrivo, costruito nella sua parte grezza e coverto in questo maggio 1937, non ha altro scopo che di ospitarvi, gratuitamente, infermi poveri, quelli cioè che per mancanza di mezzi non possono curarsi in famiglia o subire operazioni chirurgiche. Quando poi sarà dichiarato Ente stabilirò meglio le norme da seguirsi. Senonché il mio concetto e la mia intenzione è fermamente quella di ricevervi i poveri. Una tale costruzione, sotto il solo impulso della Carità Evangelica, fu fatta con i miei sacrifici e mie industrie personali. Ad eccezione di quelle poche migliaia di lire raccolte presso gli amici e pubblicate sul Charitas dell’epoca, per comprarne il terreno. Ebbene, dichiaro che TUTTO, dopo la mia morte va a beneficio dell’OPERA, che come spero s’ingrandirà senza che i miei eredi avessero nulla a pretendervi. Voglio solo che in tale opera, da me iniziata e sostenuta in mezzo a mille contrarietà e livori entrino nell’Amministrazione un membro del Rev.mo Capitolo Cattedrale o il Parroco dello stesso Capitolo, qualche Autorità Statale, il Capo del Comune ed un discendente in qualunque grado sia della famiglia del mio germano Angelo Custode. Per me, dell’opera che sorgerà non desidero altro che un suffragio per l’anima mia nelle Messe che vi si diranno.
Canonico Luca Petraglia
Vallo Lucano, 30 maggio 1937
Noto che:
il nome dell’Ospedale dev’essere San Luca in onore del mio Santo. Samaritano il bollettino che per avventura si stamperà sotto altro nome.Vallo, 3 aprile 1945
Il Capitolo Cattedrale prende atto all’unanimità del testamento di don Luca e nomina l’Arcidiacono don Alfredo Pinto a componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale San Luca. Don Alfredo Pinto, il quale già si era distinto nella realizzazione di altre opere di interesse religioso e sociale, si mette subito al lavoro e, nel 1950, ottiene un importantissimo risultato: l’Ospedale per i poveri San Luca di Vallo della Lucania viene eretto in Ente Morale con Decreto del 13 marzo 1950, n. 707, firmato dal presidente della Repubblica Luigi Einaudi. Il patrimonio viene valutato in venti milioni di lire. Con il medesimo atto viene approvato lo statuto, composto di 25 articoli. In primo luogo lo statuto prevede che ”l’ospedale debba venire in aiuto degli ammalati poveri del Circondario di Vallo della Lucania, ossia dei Comuni appartenenti ai mandamenti di Vallo, Gioi, Laurino, Laurito, Torre Orsaia, Vibonati, Camerota, Pollica, Torchiara e Castellabate”. Per i poveri il mantenimento in ospedale sarà gratuito ma possono essere ammessi alla cura anche ammalati non poveri, salvo il pagamento delle rette in misura da determinarsi. Le prime fabbriche vengono rimodernate; la suddivisione interna dei locali resa fruibile ed adeguata alle esigenze di un ospedale moderno.
Dopo la morte del fondatore e l’erezione in Ente Morale l’Opera è diretta da un Consiglio di Amministrazione formato da rappresentanti del Capitolo Cattedrale, della Provincia di Salerno, del comune di Vallo, della famiglia del fondatore. Oltre al presidente, don Alfredo Pinto, ne fanno parte in qualità di consiglieri gli avvocati Luigi Scarpa De Masellis, Attilio Di Paola e Gaetano Di Vietri, il fratello di don Luca, Angelo Custode Petraglia, ed il segretario comunale di Vallo della Lucania, Michele Salati. Nel settembre del 1953 il consiglio di amministrazione invia una petizione a tutte le autorità locali e nazionali per chiedere i fondi necessari per la realizzazione di un’Opera che, basandosi sulla legge della carità, sarà di sollievo e conforto a tutti i poveri della nobile Contrada Cilentana.
La nuova struttura, che potrà ospitare oltre cento ammalati, non è ancora completa; si sono spesi molti milioni ma per fare funzionare l’Opera ne occorrono altri quattordici. La morte di don Alfredo Pinto, avvenuta il 2 luglio 1955, interrompe anche questa seconda attività esuberante in favore dell’ospedale le cui sorti sembrano ormai segnate. Invece, anche stavolta le cose ricominciano a girare per il verso giusto allorquando il Capitolo Cattedrale designa un altro sacerdote, il canonico mons. Pietro Guglielmotti. Grazie alla sua opera intelligente e appassionata, favorita anche dal mutare dei tempi, l’ospedale decolla definitivamente.
Mons. Guglielmotti, non inferiore per qualità e spirito di sacrificio ai suoi predecessori, pone le basi per il futuro sviluppo del presidio che con il passare degli anni diventa un importante punto di riferimento per la sanità salernitana.
[...]